Tonino Caputo: dell'irreversibile nomadismo
Di Francesco Boni
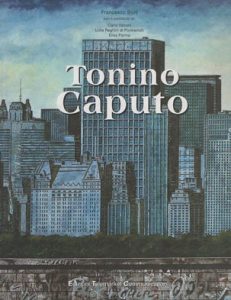
Pensando al dipingere di Caputo, artista di Lecce, ma romano d’adozione, arrivato giovanissimo nel dopoguerra a contatto con la tradizione dei Mafai, dei Gentilini, degli Stradone, dei Capogrossi, dei Turcato ed in contrasto con il neo-realismo guttusiano, mi viene in mente una frase pronunciata nel 1913 da Fernand Léger: “La moderna concezione dell’arte è l’espressione totale di una nuova generazione, di cui condivide la condizione e le aspirazioni”. Essere moderni in questo senso, significa prendere parte a tutti i cambiamenti apportati alle condizioni di vita. Questo vuol dire accettare gli elementi dell’inconscio, dell’irrazionale, che interagiscono nell’ambito delle vicende umane. Questo vuol dire rovesciare la tirannia imposta dall’arte e dal pensiero più sofisticato e comprendere che l’arte contemporanea. l’arte nuova, la vera arte in rapporto al proprio tempo, non può che sorgere da altre idee dell’attività umana. Significa guardare alle opere di altri popoli piuttosto che riverificare le aree a noi conosciute di Atene, Firenze, Roma o Venezia. Significa credere, come credeva Léger, che un manifesto, un oggetto, una macchina abbandonata in mezzo ad un campo, potessero arricchire e non sminuire un paesaggio. Vuol dire accettare la modernità, l’aeroplano, l’astronave, le costruzioni in acciaio e cristallo, i mezzi di comunicazione, come strumenti di liberazione. Vuol dire guardare alla nostra eredità umana come ad un tutto, senza paure e senza pregiudizi.
Negli anni Sessanta tutto questo era già definito, già chiaro e scolpito nella personalità di Caputo, che sentiva il fascino degli artisti già maestri della prima metà del secolo. Proprio per queste convinzioni nel 1957 non si indignò quando Pierre Restany presentò a Milano la mostra scandalo di Yves Klein, dove furono esposti per la prima volta in Italia undici quadri monocromi blu. Fece sue le parole di Restany “un istante di verità, senza il quale né io né altri potremmo avere né amore, né arte, né poesia, né emozione pura. Attenzione: queste enunciazioni monocrome – avvertiva il critico – esigono tutto quel patrimonio di disponibilità che occorre per fare le rivoluzioni e debellare i tiranni. Uomini moderni, oppressi da un’eredità intellettuale, intossicata di oggettività, di forma, di ritmo, che specie di reazione avrete voi dinnanzi a questo fenomeno di pura contemplazione? Senza il pur minimo discorso prestabilito, senza l’apporto di qualunque figurazione oggettiva, senza fermare la traccia segnata dal gesto, Yves Klein vi invia, in un clima da lui voluto di comunicazione tutta immediata, la scala di tutti i tesori effettivi del colore: di un colore, un blu, un blu autonomo, disancorato da qualunque giustificazione funzionale…Siamo dinnanzi al blu-signore, padrone assoluto della più definitiva tra le frontiere liberate, il blu degli affreschi di Assisi: questo vuoto colmo, questo niente che afferma il tutto possibile, questo soprannaturale silenzio astenico del colore, questo x, infine, che al di là dell’aneddotico e del pretesto formale, determina l’immortale grandezza di un Giotto”.
Perché citare Klein per descrivere poi un pittore figurativo come Caputo? Perché Caputo ha vissuto questa emozione formativa che sarà sempre presente come sottofondo spirituale, poetico, nei suoi quadri.
Caputo visse intensamente quegli anni, conquistò esperienze nell’ambito dello sviluppo di una pittura variamente oggettuale, addirittura narrativa, che trovava conferma nella frequentazione dei maestri italiani del Novecento, e fu conquistato dalle nuove ricerche di Klein e degli Americani. Era attento alle ricerche di Manzoni e dei Milanesi, ma guardava con occhio quasi paterno e compiaciuto a ciò che accadeva nella Roma decadente e barocca degli anni Sessanta. Conobbe Francesco Losavio, Fabio Mauri, Jannis Kounellis, Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, ma non si orientò come loro a soluzioni monocrome, anche se abbastanza differenziate al loro interno. Condivise di più quello che fu l’orientamento successivo della ricerca di quegli anni, e che Gillo Dorfles chiamò l’arredamento urbano; a questo punto una frequenza sempre più incalzante di frammenti di immagini tratti dal mondo dei mass-media invase la sua opera e solo più tardi, a partire dalla fine del ’62, anche quella di tutto il gruppo romano.
Caputo visse la poesia dell’assoluto (Klein), ma capì che per dialogare con l’esterno bisognava comunicare con un nuovo linguaggio, una sorta di “realismo di massa” che utilizzava deliberatamente le immagini stereotipate, banali, una sorta di “paccottiglia visiva”. Nacque la “coscienza” in Caputo di non poter ignorare le popolazioni nuove, i pubblici nuovi, il potere della comunicazione in tempo reale che è irrefrenabile; in tutto il mondo maturava un potenziale di spettatori dell’arte a cui il linguaggio dell’arte doveva arrivare. Era un pubblico che doveva godere degli stessi diritti che per secoli erano stati privilegi di un picco-lo numero di poeti, conoscitori, critici ed artisti.
Pochi critici in quegli anni riconobbero a Caputo il merito di aver intuito lo sviluppo dell’arte di fine millennio.
Molti si dedicarono a cercare il peso delle influenze che provenivano ai pittori romani, Caputo compreso, da quell’area americana del New-Dada che andava definendosi nella Pop-Art. Gli artisti romani ne avevano ricavato, prima di tutto, la fondamentale sollecitazione a passare da un paesaggio urbano accolto in maniera allusiva, segnaletica (manifesti, cromie, schermi), ad una realtà visiva ricavata dai mass-media, prelevata nell’evidenza oggettiva od addirittura ingombrante delle sue immagini, comprese le riproduzioni fotografiche o stampate di famose opere d’arte del passato. Dagli americani era importante ricavare non tanto alcune iconografie pubblicitarie (Schifano), quanto soluzioni tecniche o stilistiche rivolte a serializzare l’immagine ed evidenziare la natura fotografica fin dall’origine (Festa).
Queste le esperienze di Caputo giovane, i contatti con Mafai, la memoria della prima Scuola Romana con De Chirico, l’acquisizione del senso del mistero della Metafisica, quindi delle voci di dentro, l’acquisizione del senso della poesia universale con Klein, la partecipazione all’esplosione culturale degli anni Sessanta e la Pop-Art. E’ così che nasce la poetica di Caputo, che di fronte ad un mondo che si pretende positivo, un mondo che si richiama al realismo, un mondo apparentemente e disperatamente uniformato, sente rinascere il desiderio primario dell’altrove. Molte volte l’artista visse la preoccupazione di esse-re a parte. di non aderire ai valori comunemente accettati o ritenuti tali. Fortunato Bellonzi capì in quegli anni ormai lontani che dalla sintesi di elementi formativi così ampi e dalla naturale predisposizione di Tonino Caputo ad adeguarsi, ad essere specchio e testimone del pensiero a lui contemporaneo, sarebbero scaturite soluzioni uniche nel mondo dell’arte, soprattutto aderenti allo sviluppo della nostra società.
E proprio questa visione premonitrice, inattuale negli anni Sessanta. ma già conquistata in quel periodo da Caputo, che ora risorge in maniera straordinariamente diffusa. Oggi il desiderio del divenire, più o meno coscientemente, è parte integrante del pensiero contemporaneo ed invita ad un vagabondaggio intellettuale le cui conquiste possono essere illimitate. L’amore di Caputo per l’America, ed in particolare per New York, nasce da una realtà obbiettiva: è la prima città al mondo in continua e vissuta trasformazione, mai uguale a se stessa, divenuta esempio e forza viva del pluralismo perché si esprime in modi differenti: dai molteplici sincretismi religiosi e filosofici alle avventure sportive o esistenziali, dal vagabondaggio sessuale al turismo più convenzionale.
In tutti questi casi è la stessa idea di mondializzazione o di pensiero unico a venire criticata. Sembra un paradosso, ma la città da cui proviene l’idea della globalizzazione è il simbolo stesso dei no-global! Infatti, che se ne abbia consapevolezza o meno, Runica denominazione comune di tutti questi fenomeni è proprio il riconoscimento della diversità delle culture, il tenere conto della pluralità dei fenomeni umani e naturalmente del relativismo che è conseguente a tutto ciò.
Caputo è cosciente-del fatto che viviamo un periodo di cerniera, e lo esprime da anni attraverso la sua pittura. La nostra realtà si basa sul paradosso di una società che dà vita ad un apparente od addirittura reale uniformazione ed allo stesso tempo ad una concreta differenziazione degli specifici particolarismi. Da un lato i valori comuni ostentati, rumorosi, dilaganti, valori magnificati o condannati dai media e dai poteri economici e politici. Dall’altro la rinascita dei valori radicati, con arcaismi di pensiero che credevamo totalmente estirpati; insomma una celebrazione, nel bene e nel male, di un tribalismo inasprito, di cui oggi sarebbe assurdo negare l’importanza e di cui sarebbe sciocco ignorare gli effetti.
Caputo sa che una tale dialettica altro non è che il segno della nascente post-modernità. Se un artista per essere tale deve essere il testimone della più diffusa delle dialettiche a lui con-temporanee, allora egli ne è il portatore e diffusore da anni, nomade e proselita di una globalizzazione positiva, cosciente al tempo stesso che anche la società tribale è strutturalmente frammentata. L’eterogeneità è la sua caratteristica essenziale. Ciò può sorprendere colui che esamina la realtà che viviamo in prospettiva miope. Ma colui che è abituato a frequentare Gian Battista Vico, sa riconoscere l’andirivieni delle vicende umane: sa che dopo un periodo dominato dall’unità non si potrà che assistere al ritorno della molteplicità.
Il tempo che viviamo esige un’arte alternativa, qualcosa che permetta all’istinto creativo di emergere con piena forza ed al tempo stesso valorizzare la coscienza del passato; dovrebbe nascere da un’intuizione individuale ma al tempo stesso essere comune allo sterminato popolo dei fruitori dei media. Dovrebbe essere pronta ad una rottura definitiva con i luoghi comuni, ma al tempo stesso testimone di una realtà di luoghi comuni.
Sono cinquant’ anni che Tonino Caputo percorre questa strada accompagnato da una radicata abitudine a lavorare in sintonia con l’uomo comune, incarnando la figura del nomade che deve adempiere al suo destino. Destino che porta con sé il sentimento tragico dell’esistenza. È questo che fa della vita e del dipingere qualcosa di perfettamente quotidiano e strano al tempo stesso. Vita fatta di abitudini ed avventure. Questa è l’originalità del destino tragico; niente è sicuro, e tuttavia nei casi oggettivi dei rituali quotidiani possiamo scorgere avvenimenti dalle conseguenze imprevedibili. È questa la dialettica del centro e dell’estraneità! È il sentimento della vita come avventura che può essere vista in molteplici modi: il vagabondo, il senza fissa dimora, il girovago, il turista, l’avventuriero, tutte modulazioni differenti dello stesso archetipo.
Che artista Caputo, capace di vivere un itinerario che parte dai romanzi, dalle commedie, dalle poesie che nutrono la nostra immaginazione, per passare al mondo della comunicazione, dei media, della Pop-Art, fino alla teorizzazione del no-global. E tutto comincia dal sogno che agisce nella maggior parte dei casi come un primo sistema d’allarme. Porta un messaggio urgente ed incensurato dall’inconscio. Qui Caputo comprende De Chirico. Ed è d’accordo con Edgar Allan Poe quando scrive che “tutto ciò che vediamo o sembriamo non è altro che un sogno dentro un altro sogno”; ma è capace di trasportare tutto questo nel mondo sociale del quotidiano adottando già a partire dagli anni Sessanta nella sua pittura l’evidenza percettiva e l’iconografia domestica delle immagini pop, pur mantenendo inalterata quella carica di atemporalità che impregnava l’arte metafisica di De Chirico e del realismo magico. Nelle sue opere conquistano la nitidezza del disegno, il colore pieno della luce, la sottigliezza e l’uniformità della pellicola pittorica e la regolarità quasi geometrica dell’immagine, conseguenza di una focalizza-zione su particolari ingigantiti di oggetti comuni o di strutture architettoniche tipiche dell’urbanesimo moderno. Sono questi elementi che portano la pittura di Caputo verso una ricerca di sublime purezza formale, retaggio di una tradizione tutta italiana, partita da Piero della Francesca e pervenuta fino al ‘900 attraverso la Metafisica. L’assoluta verità è fondamentale per questo genere di quadri, ed è implicito in essi che la pittura, finché sarà così strettamente legata ad una realtà del dubbio, non potrà mai venir rimossa dalle sue funzioni. Quando il vero ed il giusto vengono menzionati in connessioni a questi quadri, ci ricordiamo che il vero ed iI giusto conducono ad una connotazione morale che non si lega con il dubbio metafisico. L’opera che nasce da un tipo di impostazione del genere potrebbe rischiare di essere noiosa e schematica, certo ben argomentata, ma arida. Ma in essa è viva la maggior parte delle tecniche adottate dai pittori più famosi; allusioni, ambiguità libertà di riferimenti, diniego di stabilire modelli ideali di bellezza, possibilità di compiere mutamenti di ritmo, tono ed intento all’interno dello stesso quadro.
La pittura di Caputo è un omaggio a quegli artisti capaci di suscitare dei sentimenti là dove non erano mai scaturiti, capaci di far convivere gli elementi più contrastanti del percorso culturale degli ultimi quarant’anni. Caputo rappresenta la coscienza dell’artista della sua generazione; possiamo infatti concludere con le parole di Zweig ne “Il candeliere sepolto”: “Forse il nostro destino è quello di essere eternamente in cammino, rimpiangendo senza fine e desiderando con nostalgia, sempre assetati di riposo e sempre erranti. Benedetto è infatti soltanto il cammino di cui non si conosce la meta e che non di meno ci si ostina a servire, tale la nostra marcia in questo momento attraverso l’oscurità ed i pericoli senza sapere ciò che ci attende”.
