La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte (Omar Khayyam)
Di Giorgio Barassi
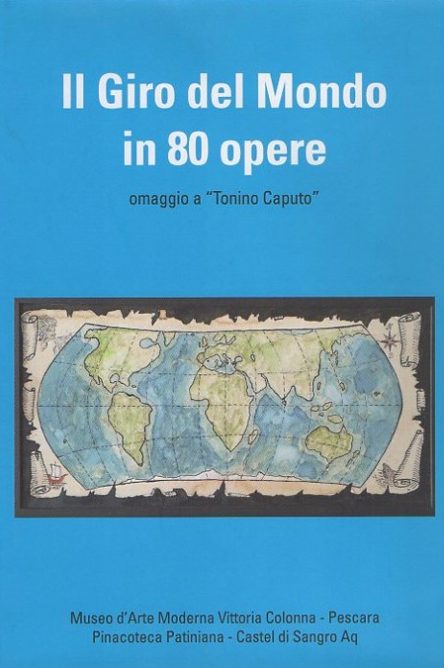
Contarli? A che servirebbe? Elencarli? Gli elenchi non sono materia per anarchici autentici, per gente libera come la mente che ha. Non l’ombre di un pregiudizio, non l’allevamento della maldicenza, niente. Caputo è un puro viaggiatore, non un turista. Sia chiaro, e lo sia prima di tutto. Dunque la conta dei viaggi accumulati in una vita è povera cosa rispetto al contenuto interiore, alla potenza espressiva, alla capacità di analisi che il muoversi nel mondo ha fatto crescere in lui, alimentando solo il suo desiderio di indipendenza senza il margine di una lontana barriera, fosse pure facilmente scavalcabile. Questo definirebbe un autonomo portatore di una propria fede, una sorta di irregolare, insomma uno a cui non affidare nulla. Invece non è così, perchè Caputo conosce fin troppo bene il valore delle proprie radici, come ben conosce le ragioni e i valori della scienza che ha permesso di codificare quelle regole che lui studiava alla facoltà di architettura a Roma e l’importanza dei Maestri della Pittura a cui ha rivolto concreta attenzione. Ma mettere un uomo libero su qualche binario è vicenda perdente, e allora, meglio viaggiare col vento in faccia, al solo scopo di viaggiare. Fosse un fatto da viaggiatore ottocentesco, avremmo diari con descrizioni goethiane, prosa o poesia sugli incontri, sui luoghi. Ma a Caputo interessa dipingere, e gli angoli delle vie limitate dal bianco abbacinante di Santorini o il salotto nitido e fermo delle vie di Stoccolma non sono differenti, nella sua poetica. Una birra fresca è la stessa a Praga, a Parigi e a Parma. Cambia il sapore e magari il costo, ma quello del quotidiano, il tavolino sulla piazza, è il punto che guarda il mondo, per lui.
Potrebbe raccontare degli incontri, fortunati o meno, fatti nella Roma degli anni 50 coi grandi della pittura di allora, che lo guardavano sospettosi perchè ancora impolverati di conformismo e dalle pregiudiziali della loro formazione. Potrebbe vantarsi del carteggio con Piero Manzoni o dei successi alti degli anni sessanta, di quei soldi degli anni seguenti, ma niente, Lo fa quando e se glielo chiedi, perchè l’argomento scotta. Potrebbe semplicemente elencare i luoghi in cui è stato, è passato ed ha vissuto, ma lo fa solo se deve riferire quanto è accaduto, dentro di lui, la o da un’altra parte. Di cosa gli è rimasto appiccicato addosso e di cosa lo abbia spinto ad elaborare, ad esempio, quei dipinti degli anni ottanta in cui i fabricati newyorkesi, i ponti di ferro, le scritte sui muri del bronx diventano documenti del perenne contrasto tra la furia costruttrice dell’uomo e la solidità silenziosa delle sorde fabriche di un secolo prima. Basta vedere quelle opere e capire che il suo racconto è pieno di viaggi veri, di visioni, di scorci ricchi di significato. Pieno nel racconto della pittura, della gioia di aver capito e saputo. Perchè il viaggio di un artistanon è solo di andare da qui a li, fosse anche un altrove lontanissimo. Anche quando, per intuito e denuncia, il Caputo della “Nuova Metafisica” (il termine è di Fortunato Bellonzi) mette, ad un certo punto della sua poliedrica produzione, tra se e quel che dipinge una grata, un reticolo perfetto che ostruisce ma invoglia alla visione. Caputo non si è mai sottratto alla voglia di violare il segreto, non si è mai sottratto alla voglia di violare il segreto, mai si è ritirato dal desiderio di scoperta a costo della avventurae della disavventura, mai una nota di rimorso nel suo vagare per il mondo quanto tra le pieghe della pittura che lo ha visto informale, astrattista, neometafisico e vedutista moderno. Prima di altri ha cantato la New York assolata dei grattacieli sfavillanti o grigia delle periferiepronte ad esplodere di rabbia. Più di altri ha lasciato i segni dei luoghi visitati e vissuti, perchè li ha vissuti davvero e una foto o i racconti di altri non gli basta mai. Non gli potrebbe mai bastare.
A confronto della sua dipendenza assoluta e della sua fiera autonomia, vengono le parole dello stesso Caputo, scritte sul libercolo “Caputo – l’itinerario artistico di un pittore nomade” (a cura di M. Beraldo, Canova, 2004): … nel 1967 inizia un ritratto di Che Guevara, ma quando cominciai a vederlo impresso nelle magliette come un i-cona, smisi di farlo e da allora non l’ho mai ripreso…
Nemmeno le frequentazioni importanti, gli artisti e i poeti conosciuti da tempi lontani, la storica litigata col suo amico Carmelo Bene (Tonino aveva ben ragione di reagire la primadonnaggio del grande attore) e le vicende ondivaghe della storia commerciale dell’arte lo hanno dissuaso da una intenzione di viaggio che fosse elemento di stimolo, struttura e propulsione, elemento e decoro insieme. Bruce Chatwin nella Anatomia dell’irrequietezza parla di “Horreur du domicilie” e si sa. Ma Caputo prende la vicenda del viaggiatore un fatto costruttivo della sua vita, e perciò la ragione del viaggio si piega a metà di fronte allo spaziare di elementi determinanti quanto un cromosoma che lo spingono ad adeguare la sua esistenza al ritmo degli aerei, dei treni, delle navi e delle macchine usate per girare il mondo e viverne le storie, che finiscono irrimediabilmente in un quadro: la sua maniera favorita di spiegare una interiorità sensibile e ruvida quanto sofferta ma fermamente goliardica. In ogni suo viaggio è una storia, come in ciascuna delle città, dei porti, degli aereoporti, da cui non sia solo passato e da cui ha preso spunti magnifici per un atlante ricco di umanità.
La apparente, non ai più accorti, rassegna di immagini dedicate alla tante città vissute sembra avere un comune denominatore nelllo stile utilizzato, che è riconoscibile e segna il senso delle sue opere. Eppure un tono, un leggero comparire di una tinta favorita o sfavorita nella stesura dell’opera, lascia trapelare le differenti sensazioni che di fronte ad ognuno di quei posti Caputo ha intimamente provato non facendosene carico diretto, ma semplicementerecependi il vero significato di ponti, strade, acque, insegne, marciapiedi e balconate come elementi di aiuto per un vedutismo che non ha tempo per smancerie descrittive. È di un illuminismo autentico, pur vibrando delle intensità dei rossi ed accendendosi di azzurri improvvisi, magari innaturali, ma ricchi di quanto le città rendono all’uomo in fatto di sorpresa, compiacimento o malinconico ricordo. Caputo racconta e dipinge allo stesso tempo, riferisce il vissuto ed esalta le note delle torri meno note, come la razionalista torre di Addis Abeba, lo sciabordio delle acque confluenti della Motlawa e della Vistola a Danzica e non quello della Senna sotto la scia di un Bateau Mouche, E così l’accalcarsi di costruzioni sulle acque di Bangkok è parte congenita della sua produzione, quanto le case ordinate di Bergren o la magnificenza di Petra. Sono viaggi nati con lui, con la sua travolgente voglia di vivere. Non fa dunque differenza tra le sue fortunate opere dedicate a Roma o a New York e le sue, inconfondibili e singolari vedute delle tante città in cui ha deciso di posare una attenzione viva, da osservatore e referente accorto, mai da vedutista seriale fino al rischio del trito. La banalità non gli appartiene, e mai sarebbe possibile. Perchè Caputo non è mai stato, in un numero abbastanza alto di anni di mestiere, capace di viaggiare al passo imposto da altri. Ha solo viaggiato dove, come e quando pareva a lui, senza un chilometro di sconto, per fatti connessi alla sua anima di viaggiatore, che ai consuetudinari pare anima inquieta solo perchè loro non hanno mai messo veramente il naso fuori dal loro giardino, non hanno mai azzardato a qualunque rischio, non sanno quanto sia bello impadronirsi dell’anima di un luogo semplicemente vivendoci come nulla di strutturale del vivere fosse cambiato. Cioè come Caputo ha fatto.
…Per un solo dolcissimo umore del sangue / Per la stessa ragione del viaggio: viaggiare…
(Fabrizio De Andrè, “Korakhané – A forza di essere vento”)
Giorgio Barassi
